Come punto di partenza per questo nuovo articolo della serie fotografia e verità riprendiamo la definizione data in precedenza, ovvero definiamo fotografia come il prodotto dell’interazione della luce con un materiale sensibile. In questo quinto articolo vedremo come tale definizione porta ad includere naturalmente nella categoria fotografia tutta una serie di fenomeni che, per il senso comune, e per chiunque sia appena appena ragionevole, tutto sono salvo che fotografie.
Visto che siamo in vena di definizioni, diamo subito anche quella di fotosensibile (tratta dal vocabolario), in modo da aver fissi tutti i punti di partenza e procedere in modo rigoroso.
1) Fisicamente, chimicamente, sensibile alla luce;
2) di corpo, sostanza o dispositivo le cui caratteristiche siano modificabili dalla luce o dalle radiazioni;
3) biologicamente, di organismo, che reagisce agli stimoli luminosi.
Messe le carte in tavola veniamo subito al primo esempio. È stagione e già si vedono in giro già da un po’ persone dalla pelle arrossata, quindi parliamo dell’abbronzatura. L’esempio può far sorridere, ma basta pensarci un attimo per rendersi conto che tutti gli ingredienti ci sono. L’interazione con la luce, il materiale fotosensibile. Fra l’altro si parla di fotosensibilità chimica, esattamente la stessa delle fotografie su carta baritata.
I responsabili della colorazione della nostra pelle, oltre che a proteggerla, dai raggi UV nocivi per l’organismo, sono delle molecole del gruppo delle melanine, ovvero dei pigmenti delle famiglie dei poliacetileni o delle polianiline che hanno la proprietà di rendere bruni i loro copolimeri. Il meccanismo molecolare preciso dell’abbronzatura è ancora dibattuto dai ricercatori, però Wikipedia ci insegna a grandi linee come funziona la tintarella:
Sembrerebbe trattarsi di un’azione forse mediata dall’ormone melanocita stimolante, dalla vit.D3 o suoi derivati. Tale azione è in grado di stimolare la tirosinasi la quale converte poi il substrato iniziale, la tirosina, in dopa e poi in dopachinone. Segue, a cascata, una serie di reazioni ossidative, alcune delle quali potrebbero essere sotto controllo enzimatico, che porta alla produzione dapprima di chinoni e da ultimo, alla sintesi dei polimeri terminali deputati alla pigmentazione cutanea: eumelanina e feomelanina.
Azioni ossidative, che fanno subito pensare a tutte le tecniche di stampa ai sali ferrici, quali van dyke brown, cyanotipo, palladio e platinotipia, tutte tecniche che sfruttano il principio di ossido riduzione, proprio come la tintarella. La stampa al platino, fra l’altro, è una delle tecniche preferite dagli ortodossi della camera oscura, una di quelle considerate “più pure”. Beh, una bella ragazza abbronzata ha, dal punto di vista fotografico, la stessa purezza ontologica di una stampa al platino.
Gli scettici che si stanno agitando sulla loro sedia a causa di tali paragoni poco ortodossi, si chiederanno magari dov’è all’ora il negativo, senza pensare che, a meno la bella ragazza di cui stiamo parlando non sia nudista, al mare si va in genere col costume da bagno addosso.
Nella definizione originale in ogni caso non si parla di negativo, ingranditore e simili, ma solo di interazione fra luce e materia. Se proprio vogliamo mettercelo sto negativo facciamo un altro esempio. Immaginiamo una casa, una finestra al sole, una tenda e un vaso posato sul davanzale. Dopo qualche mese o al massimo anno sulla tenda rimarrà l’impronta scura del vaso, ed avremo, di fatto, una bella fotografia. Fra l’altro sfruttare la perdita di colore dei pigmenti dovuta al sole è alla base dell’anthotipo, una tecnica fotografica inventata da John Herschel, lo stesso inventore del cianotipo. Un supporto viene colorato con una tintura ottenuta a base di piante, una volta esposto al sole per lunghi periodi il pigmento si scolora permettendo appunto di ottenere l’immagine, proprio come la tenda.
In questo caso comunque ci sono veramente tutti gli ingredienti presenti nella stampa fotografica tradizionale. Non si usa l’ingranditore è vero, ma la maggior parte delle tecniche di stampa utilizzate durante i primi cento anni di storia della fotografia (ancora una volta, quelle considerate “più pure”) non usano ingranditore. I materiali diffusi all’epoca infatti erano talmente poco sensibili agli ultravioletti da rendere inapplicabile l’ingrandimento. Le stampe venivano quindi tutte eseguite per contatto, utilizzando uno speciale strumento per premere insieme negativo e carta, che si chiama torchietto o pressino. Il contatto serve unicamente per riprodurre al meglio i dettagli del negativo, ma non è necessario e non è certo una delle proprietà fondamentali della fotografia. Del resto c’è chi sfrutta gli effetti del mancato contatto fra negativo e carta a fini creativi. Anni fa vidi la mostra di fotografo che metteva una biglia sotto al foglio in modo da avvallare la carta e ottenere una messa a fuoco selettiva. Non ho prove certe, ma in certi casi ho la sensazione che anche Mario Giacomelli e Raymond Meeks hanno fatto qualcosa di simile. Dall’altra parte, il contatto, anche con i migliori pressini, non è mai perfetto, soprattutto se si usano carte testurate, o che hanno la spiacevole tendenza ad imbarcarsi. Ancora una volta una frazione di millimetro in un torchietto o i centimetri del vaso non fanno nessuna differenza dal punto di vista concettuale.
Una delle proprietà fondamentali della fotografia citate in aggiunta a quella dell’interazione fra luce e materiale sensibile è quella dell’uso di un “dispositivo fotografico”. Magari si pensa subito alla macchina, con tutto il suo complesso corredo di autofocus, esposimetro, lenti taglienti alla linea per millimetro e via dicendo. Eppure esistono molti modo di fare fotografia ben più rudimentali, dagli utilizzatori delle macchine ottocentesche agli amanti della fotografia stenopeica, un modo di fare fotografia senza lenti, che parte solo dal principio della proiezione di un’immagine su una superficie, che già ha alcune analogie con l’ombra di un vaso proiettato su una superficie. Le macchine stenopeiche, o se vogliamo il dispositivo fotografico, possono essere veramente molto semplici. Thomas Bachler
Un negativo quindi è sicuramente una delle forme di base di dispositivo fotografico. Il negativo può essere incollato al materiale sensibile o posizionato un po’ lontano da questo, può essere traslucente come le lastre fotografiche al collodio oppure opaco come un vaso, ma sempre di “dispositivo fotografico” si tratta. Fotografie realizzate in questo modo infatti ne esistono a bizzeffe, dai primi esperimenti con piante e merletti che hanno segnato la nascita della fotografia e che sono stati già citati nell’articolo il disegno di luce e la persecuzione dei greci, agli esempi illustri dei radiogrammi di Man Ray, le Schadographie di Christian Schad o i fotogrammi di Moholy-Nagy. Tutti questi noti artisti in ogni caso posavano oggetti su materiali sensibili e ne registravano la traccia lasciata dalla luce sul materiale sensibile.
Un esempio infine di fotogramma cui siamo tutti familiari, un esempio in tutto e per tutto uguale a quello del vaso e della tenda sono le radiografie fatte negli ospedali. In questo caso il negativo sono le nostre ossa (e in parte minore anche i tessuti molli), e proprio come nel caso della tenda queste non sono messe a contatto con la lastra, quella che viene registrata è praticamente “l’ombra” delle nostre ossa.
Naturalmente le tende sono solo un esempio, praticamente tutti i materiali che ci circondano si scolorano alla luce, la plastica polimerizza, la vernice di una porta si scrosta, la segnaletica stradale impallidisce. In pratica siamo circondati da fotografie senza saperlo, quasi ogni oggetto su cui posiamo gli occhi è una fotografia, semplicemente l’esposizione è molto lunga e l’immagine del sole non è quasi mai a fuoco.
Dire che queste non sono foto perché l’esposizione in realtà è troppo lunga non ha molto senso, visto che i tempi di esposizione di qualunque foto, non sono mai istantanei, ma si tratta sempre di intervalli di tempo finiti e quantificabili. Se non fosse così non butteremmo mai via le foto che son venute mosse perché c’era poca luce e abbiamo dovuto utilizzare tempi lunghi. La notte poi la posa può protrarsi molto a lungo, le foto di cinema di Hiroshi Sugimoto durano il tempo di uno spettacolo e alcune fotografie di Michael Wesely addirittura anni, tanto che il titolo è la data di inizio e di fine esposizione.
Un esempio di “fotografie” invece che non hanno bisogno di tempi di esposizione biblici e che, a meno di patologie, non sono sfuocate, sono i nostri stessi occhi. Nella retina infatti si trovano due ricettori biologici alla luce: coni e bastoncelli. I primi, una volta stimolati dalla luce, producono un pigmento chiamato iodopsina, mentre i secondi producono la rodopsina. Quando un fotone colpisce una molecola di uno di questi due pigmenti, questa cambia la sua struttura molecolare. Questo fa partire tutta una serie di reazioni chimiche a catena che produce un’iperpolarizzazione che rende fortemente negativo il potenziale di membrana. In seguito tutta una serie di reazioni nervose hanno come risultato finale la visione del mondo che ci circonda. Quello che avviene nei nostri occhi però, di fatto, ancora una volta ha tutte le caratteristiche della definizione data per fotografia: l’interazione della luce con un materiale chimicamente fotosensibile.
Un altro esempio di fenomeni che rientra nella definizione di fotografia, fenomeni che non sfruttano semplicemente l’interazione di pigmenti e luce sono le foreste e le piante in generale. Una pianta al sole cresce, ovvero modifica se stessa. Ci vogliono i sali minerali e l’acqua perché ciò sia possibile, ma anche alle foto sono necessari i bagni di sviluppo, che spesso non sono altro che sali sciolti in acqua. Di fatto quindi il pratino intorno a casa è lui stesso una fotografia.
A questo punto gli scettici diranno che le foreste non sono un’immagine, sono dei corpi tridimensionali nello spazio. Ancora una volta sarebbe necessario fare delle aggiunte alla definizione, dire che non basta che la fotografia sia un prodotto dell’interazione della luce, ma deve essere un’immagine e bidimensionale. Se proviamo a definire immagine entriamo in un altro vespaio simile a quello che ci ha portato la ricerca di una definizione di fotografia, e in ogni caso ci sono moltissimi esempi di fotografie che non sono assolutamente bidimensionali. La stampa al carbone sfrutta proprio lo spessore della gelatina per costituire l’immagine, anzi, questa è proprio una delle caratteristiche che ne fanno la bellezza e che la rendono così appetibile ai maghi della camera oscura tradizionale. Le stesse fotografie ai sali d’argento e i negativi in un certo senso creano l’immagine grazie allo spessore dello strato d’argento, quindi sono solo macroscopicamente bidimensionali. Lo scarto fra le frazioni di millimetro in gioco in queste fotografie e i centimetri dell’erba di un prato ancora una volta da un punto di vista concettuale non fanno alcuna differenza. È comunque facile immaginare una stampa al carbone fatta con gelatina talmente scarica di pigmento da far diventare le stampe macroscopicamente tridimensionali.
Bene, siamo già nell’assurdo più completo, visto che siamo già arrivati a definire fotografie tutti i materiali che reagiscono alla luce, comprese le piante. Ma cosa succede se prendiamo anche le altre due possibili espressioni di fotosensibilità, ovvero quella biologica e fisica? Nel primo caso, volendo esagerare un po’, la meteoropatia è anch’essa fotografia, quando piove per giorni e ci sentiamo depressi perché ci manca il sole il nostro stato psicologico è pure lui una fotografia. Di fatto, è una razione di un materiale sensibile (noi, il nostro corpo e la nostra mente) alla luce del sole.
Per quanto riguarda la fisica gli esempi comunque sono molto più plausibili. Ogni impianto fotovoltaico allora è una fotografia, la temperatura che aumenta di un secchio d’acqua messo al sole fa di esso una fotografia, un optoisolatore è una fotografia, i ghiacciai che fondono (cambiamento di fase, da solido a liquido) sono fotografie.
Ma anche il vento stesso è una fotografia. Il motore della circolazione globale sulla terra è infatti il sole. Semplificando si può dire che il suolo si riscalda il suolo diversamente secondo la latitudine: forte flusso termico all’equatore e ai tropici e via via sempre meno se si va verso i poli. Il suolo caldo riscalda anche l’aria a contatto di esso, che diventa più leggera e per il principio di Archimede si innalza verso le parti alte dell’atmosfera. Visto che per continuità quest’aria deve necessariamente essere rimpiazzata da altra aria, si crea, oltre al movimento ascensionale, anche uno spostamento orizzontale di masse d’aria. Poi la rotazione della terra e la forza di Coriolis fa il resto, deviando i venti e creando per esempio gli Alisei, venti che hanno reso possibile le rotte di navigazione del passato. Lo stesso fenomeno ma ha scala ridotta è ben noto del resto ai velisti, la brezza termica ha esattamente la stessa origine, l’unica differenza è che il gradiente di temperatura invece che essere nord-sud è fra mare e terra. Ebbene, il vento alla fine dei conti è il prodotto della luce (energia solare) su un materiale sensibile (il suolo, che reagisce scaldansoi all’irraggiamento solare), quindi a rigor di logica anche il vento è una fotografia!
Si potrebbe obiettare che la risposta biologica e la fotosensibilità fisica niente hanno a che vedere con la fotografia, che è necessaria della fotosensibilità chimica (ancora un’aggiunta alla definizione, alla faccia che la discriminante è quindi la luce). In ogni caso ci si restringe al chimico gli occhi fanno comunque fotografie, la pelle abbronzata, i materiali che stingono restano comunque fotografie. Ma è comunque difficile restringersi solo alla fotosensibilità chimica. Infatti, sebbene non conosca nessuna tecnica di stampa biologica, esistono un discreto numero di tecniche fotografiche (e varianti di queste) che fanno uso di modifiche fisiche del materiale per produrre l’immagine. Le tecniche antiche (utilizzate per decenni prima della nascita della fotografia ai sali d’argento come la conoscono tutti) si dividono infatti in due grandi categorie: quelle ai sali metallici e quelle ai colloidi. In quest’ultima categoria rientrano la già citata stampa al carbone, la gomma bicromata, quella alle polveri e le resinotipie.
Nel caso della stampa al carbone e della gomma, un colloide, gelatina nel primo caso, gomma arabica nel secondo, in presenza di dicromato di potassio diventa insolubile. L’immagine viene quindi creata sfruttando lo spessore dello strato di colloide, che trattiene in misura più o meno minore un pigmento aggiunto alla mescola. Nel caso della stampa alle polveri si sfrutta la proprietà della gomma arabica di divenire più o meno appiccicosa. Nella resinotipa, ideata da Rodolfo Namias attorno agli anni 20 del secolo scorso, si sfrutta il rigonfiamento della gelatina, ovvero le differenze di igroscopicità di questa. Esistono poi infinite varianti, stampe alla caseina, alla tempera, all’“uovo intero”, stampe alle polveri o resinotipie di Obernetter, di Sobacchi, Giuseppe Devincenzi etc.
Il meccanismo di cross-linking che porta all’indurimento della gelatina non è ancora noto in dettaglio, ma si tratta di legami fra molecole, che determinano poi le caratteristiche di durezza, viscosità, idrofilia, dello strato della gelatina. Si tratta in parte di modifiche chimiche in parte di modifiche fisiche, ma in ogni caso tutte le tecniche citate utilizzano le caratteristiche fisiche del supporto al fine di creare l’immagine.
Se si accetta poi che le stampe digitali a base di inchiostro sono comunque fotografie anche quelle stampate con una stampante laser lo sono, e questa utilizza un processo fisico e non chimico per produrre l’immagine. Semplificando il funzionamento di una stampante laser infatti è il seguente: un raggio laser viene modulato secondo l’immagine che deve essere stampata e viene inviato su un tamburo elettrizzato che si scarica dove viene colpito dal raggio luminoso. I pigmenti (polverizzati assieme ad altri materiali sintetici) ovvero il toner, vengono attirati grazie all’elettricità statica sul tamburo. Questi poi vengono trasferiti su carta e infine un rullo fonde il toner per fissare l’immagine sulla carta.
Concludiamo questo articolo un po’ pazzo anticipando una domanda dei lettori. Sei serio quando dici che anche le piante sono foto e addirittura il vento è una fotografia? Non ti sembra un’assurdità?
Certo che è un’assurdità, ma finalmente stiamo entrando nel pieno appunto della nostra controdimostrazione per assurdo. Lo scopo di questo articolo non è voler dimostrare che il vento o la depressione sono delle fotografie, ma piuttosto mettere in luce le difficoltà cui si va in contro cercando di definire in modo univoco la fotografia. Seguendo la logica dell’interazione con la luce le stampe inkjet che si vedono nei musei di fotografia non sono foto ma “altro” mentre il vento che ci soffia in faccia d’inverno è una foto. Più assurdo di così faccio fatica a immaginarlo.
Ogni definizione che si rispetti deve essere breve e sintetica, includere tutte le accezioni possibile e escludere ciò che non deve rientrare nella categoria. La frase lapidaria che vuole la fotografia come unico prodotto dell’interazione con materiale sensibile di per se include un’infinità di fenomeni che chiaramente niente hanno a che vedere con la fotografia. Per venirne fuori si è tentati di aggiungere una serie di distinguo: sensibilità solo chimica e non fisica, tempi di esposizione brevi, spessore al di sotto del millimetro, etc. Questo da una parte mina la brevità della definizione e rende necessari tutta una serie di distinguo, dall’altra è facile trovare controesempi di tecniche veramente fotografiche che non rispettano queste presunte caratteristiche fondamentali della fotografia che ci si vede obbligati ad aggiungere per evitare di includere tantissimi fenomeni naturali nella categoria fotografica.
Tutta la difficoltà nasce dall’eterogeneità e varietà dei procedimenti fotografici. La nostra definizione deve per forza di cose poterli includere tutti, e se vogliamo farlo è necessario essere sufficientemente generali, quindi nella nostra categoria rientrano tutta una serie di fenomeni che poco o nulla hanno a che fare con la fotografia. Nel prossimo articolo vedremo che si ha anche il problema esattamente opposto, volendo essere rigorosi infatti, la definizione data non solo è troppo larga, ma è anche troppo stretta. Non si tratta unicamente delle stampe a getto di inchiostro, vedremo che la definizione non include praticamente niente di quello che si intende generalmente per fotografia!




































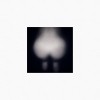



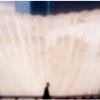












Puoi anche iscriverti al feed RSS dei commenti a questo articolo.