È mattina. Una solitaria domenica mattina. Sto andando a vedere un film al cinema, cosa effettivamente un po’ strana per una domenica mattina. Qualche giorno fa ho mandato una mail alla maggior parte delle persone che conosco che abitano a Parigi, invitandoli a venire. Sapevo che non sarebbero venuti in molti visto l’orario, ma non mi sarei aspettato di non ricevere nemmeno una singola risposta alla mia mail. Niente di niente. Mi dispiace un po’, ma alla fine più che proporre regolarmente attività, visite, film, spettacoli a cui vado quasi sempre da solo non so bene cosa dovrei fare. Che poi mi sto abituando e rassegnando, sia mai che la solitudine della citazione di Rilke nell’intervista a gUi mohallem non sia davvero di qualche utilità.
Scendo dalla RER a Saint Michel, e mi incammino verso la linea 10 del metrò. Salgo le scale e cammino per il lunghissimo tunnel deserto con il nastro trasportatore. Sono passato di qui praticamente tutti i giorni, per quasi tre anni, quando lavoravo nel laboratorio di oceanografia di Parigi 6, e oggi mi rendo conto che forse, da quando ho dato le dimissioni quasi due anni fa, non ci ero mai più ripassato, evitando accuratamente di tornare dalle parti di Jussieu, un po’ per evitare di riaprire vecchie incazzature, un po’ per non incontrare il mio vecchio capo, con cui i rapporti alla fine si erano veramente guastati. Di botto mi tornano in petto tante sensazioni quasi dimenticate. Il ricordo di tanti momenti e pensieri, la fatica dopo la giornata passata a programmare con Matlab, le speranze di allora che oggi non sono poi così cambiate, salvo veder più chiaramente che sono perfettamente illusorie.
Quando esco il cielo è nero di nuvoloni spessi, piove a rovesci che il vento spazza via e ti butta addosso. Non ho l’ombrello e -visto che sono uscito di corsa- ho dimenticato a casa anche i guanti e il cappello. Ma non mi dispiace, ho sempre amato la sensazione degli elementi sulla pelle. Sono una delle poche cose che rimangono che ti ricordano che sei vivo. Risalgo a piedi la rue de Babylone, mi guardo attorno alla ricerca di possibili fotografie, anche se non ho quasi mai dietro la macchina non smetto mai di scrutare il mondo attorno a me. Ed eccolo li. Un palazzo marrone, dai balconi di vetro, vicino ad un giardinetto. Il condominio che è stato il primo di cui ho fatto una foto, in seguito scartata, della serie dei palazzi infiniti. Mi si apre un sorriso in faccia, che si allarga sempre di più, tanto che quasi quasi mi metto a ridere da solo. E poi ecco, poco più in là, un muro che pure ho fotografato, in un’altra occasione, e so che dietro c’è una panchina che ho fotografato e -me lo ricordo benissimo- il grandangolo non era abbastanza ampio per restituire l’effetto che volevo. La città, piano piano, diventa uno stratificarsi di esperienze vissute, di ricordi, di baci date a persone amate, di litigi, di foto che ho scattato. Una specie di realtà corale e ingombrante che mi impedisce quasi di vivere nel presente, come se fossi circondato da fantasmi che non smettono di bisbigliarmi all’orecchio le loro storie ormai finite.
Il film è al cinema “la pagoda”. Me lo mostrò per la prima volta Ana, sicura che mi sarebbe piaciuto, ma quando ci andammo purtroppo era chiuso. Un palazzo della fine del diciannovesimo secolo, costruito in un stile fra il cinese e il giapponese, con i classici tetti spioventi, mura e vetrate decorate in un misto di liberty, stile orientale e viellerie de la belle époque. Non mi ricordo bene la storia, ma mi pare che fu voluto da un ricco commerciante per far piacere alla giovane e bella moglie, moglie che non sapeva resistere ai regali provenienti dal lontano oriente, allora così alla moda e apprezzati dalla Parigi bene. Purtroppo però la coppia finì per non abitare in questo loro palazzo imperiale, perché la bella lasciò il marito per un giovane collega del figlio di questi…
Nella sala d’attesa ci sono una ventina di persone, fra cui la più giovane deve avere almeno sessant’anni. Entro e cerco dappertutto Xudan, la ragazza che mi aveva parlato del film, ma sembra che mi abbia fatto un bidone pure lei, del resto le ho scritto un messaggio una mezz’oretta fa e non mi ha nemmeno risposto. Probabilmente dorme. Strano, perché i cinesi in generale si alzano presto e non fanno tardi la sera, quindi domenica mattina alle dieci e mezza non è un’ora tabù come per la maggior parte dei giovani occidentali. Mi guardo attorno sconsolato e depresso dalla solitudine e dal panorama umano che mi circonda. Vecchiette borghesi dal trucco troppo pesante, il profumo dolciastro e stucchevole da nonna, cappelli ridicoli, accento parigino intellettualoide. Possibile che un documentario non interessi nessuno che non sia pensionato? Possibile che sia l’unico “giovane” che trova piacevole per una volta andare a vedere un documentario sulla rivoluzione culturale cinese piuttosto che rientrare alle sei del mattino sabato sera? Possibile che personalmente sia una persona così noiosa da assomigliare ai vecchietti qua attorno? Sono veramente ridotto così male? Dove sbaglio?
Il profumo delle vecchie mi da la nausea, ed esco fuori, a respirare l’aria fredda del mattino. Preferisco stare sotto la pioggia che respirare quell’odore dolciastro che mi intossica. Chiudo gli occhi. In questo momento vorrei essere a migliaia di chilometri di distanza, in Antartide. Sulla mia rompighiaccio dove le sensazioni erano rudi e sincere, dove l’odore era quello dei fumi nella sala macchine e quello del mare, dove non ti mancava la presenza femminile perché tanto c’erano solo uomini, era un fatto assodato questo, non eri frustrato perché la questione del desiderio manco si poneva, eri solo con la natura, il vento gelido, le tempeste in mare. Per questo per una volta ti sentivi in pace.
Entrano tutti, Xudan non si vede, inspiro la mia ultima boccata d’aria fresca prima della fumigazione all’aroma di pensionata e entro anche io. Il film è un documentario di Hu Jie, un direttore di film indipendenti di solito dal contenuto fortemente politicizzato, che non è difficile capire perché siano completamente proibiti in Cina. E perché abbia perso il proprio lavoro e subisca continui attacchi e critiche per la sua opera. Avevo già visto un suo film al festival shadows (Si veda anche l’articolo su Qiu Anxiong), un documentario su Lin Zhao, una brillante intellettuale giustiziata in prigione, ed era stato certamente una delle migliori proiezioni del festival di cinema indipendente. Il documentario di oggi si intitola 我虽死去, che significa più o meno “Piuttosto che andarmene preferisco morire” e raccoglie la memoria di un anziano intellettuale la cui moglie, insegnante in un liceo femminile di Pechino, fu una delle primissime vittime della rivoluzione culturale, picchiata e torturata a morte dalle sue propre studentesse.
Nell’introduzione al documentario ci viene spiegato che il film non ha ottenuto nessun “visto commerciale”, quindi può essere riprodotto unicamente su dvd e non su pellicola. Per questo è vietato ad ogni cinema francese proiettarlo a pagamento, motivo per il quale l’ingresso oggi è gratuito. Curioso. In ogni caso, Hu Jie, pur essendo relativamente noto, non è nemmeno su imdb. Il tutto non può che aumentare il mio interesse e la mia curiosità, e il sentimento di partecipare a qualcosa di vagamente proibito.
Non voglio raccontare la storia personale dei protagonisti, né far riferimento a questa triste pagina di storia cinese, chi è interessato può cercare -anche se non so come- di recuperare il film. Ne parlo, e ho deciso di scrivere un articolo per Camera Obscura, perché i riferimenti alla fotografia, e gli spunti di riflessione conseguenti sono veramente numerosi.
Il film si apre con una pendola che oscilla, il tema del tempo è veramente ricorrente in tutto il film. E dopo pochi secondi con un primo piano molto stretto -di faccia- su delle mani anziane che aprono il soffietto di una vecchia macchina fotografica cinese, ne armano l’otturatore e scattano una foto muta in direzione del pubblico. Solo questo, a tutto schermo. Una macchina fotografica vista al contrario rispetto alla prospettiva del fotografo, una macchina che inverte i ruoli, come se gli spettatori del film diventassero i soggetti fotografati, come se il realizzatore volesse in un certo modo interrogare direttamente gli spettatori, chiedergli “E voi? Come siete voi? Come reagite? Come vi sareste comportati?”. Non voglio insistere molto su questa strada, che forse è un gioco un po’ intellettuale che non era nelle intenzioni di Hu Jie. Quello che mi preme sottolineare però è come il film si apra con questa macchina fotografica in primo piano che scatta, e proprio questa sarà un’immagine ricorrente di tutto il documentario. Sempre la stessa scena, sempre la stessa macchina fotografica in primo piano che scatta in direzione del pubblico. Come se la macchina fotografica facesse da pendant alla pendola scandendo anche lei il tempo, ritmando il susseguirsi delle testimonianze.
Oltre infatti ai racconti diretti dei testimoni oculari che assistettero ai fatti, il film può esser letto su molti piani. Il tema della verità della parola, della verità della macchina fotografica e della verità dei pensieri personali dei protagonisti è ricorrente e centrale. Le persone che hanno subito la rivoluzione culturale, nel ritratto che ne dà il cineasta, sembrano soffrire come di un grande complesso di colpa, sembra che autoneghino la propria verità storica, la realtà stessa. Come quell’intellettuale che cercava di salvare i rarissimi manoscritti conservati nella scuola dai giovani studenti che li bruciavano per strada, autoconvincendosi che doveva assolutamente esser riformato e rieducato per questo suo atto “antirivoluzionario”. Come il marito stesso dell’insegnante uccisa, che -una volta deceduto- desidera venga scritto sulla propria urna “nato e morto con ideali utopici”. Nel film la parola sembra quasi sempre essere incapace di erigersi a portatrice di verità. Da una parte l’antica abitudine cinese -cui faccio così fatica ad abiturami- di parlare, scrivere e lasciar intendere per parafrasi quello che si vuol dire in realtà, la parte nascosta del discorso cui si fa solo illusione è spesso quella più importante, le parole pronunciate sono di scarsissimo interesse reale. Basti pensare a Wang Fuzhi che nel quindicesimo secolo definiva i barbari come coloro che quando parlano dicono chiaro e tondo quello che pensano, in opposizione alle persone civilizzate e colte, che usano tutto un sistema complesso di riti, citazioni e allusioni. Dall’altra parte invece, dicevo, la fotografia, che sembra essere l’unica via obiettiva per documentare la verità. Esemplare in questo senso il fatto che, appena il protagonista del documentario scopre l’omicidio della moglie, compra una macchina fotografica -la stessa che scandisce il ritmo di tutto il film- e fotografa il cadavere della moglie, il corpo gonfio, il volto livido e tumefatto.
Nella serie verità e fotografia ho ripetutamente insistito sul fatto che la fotografia e verità non fanno assolutamente rima. Anzi, che in generale la gente si fa fregare proprio dal fatto che automaticamente incolla una sorta di verità e autenticità alla fotografica, caratteristiche che considera fondanti del media stesso. Ho insistito a lungo su quanto questo atteggiamento in generale sia sbagliato. Però negli articoli successivi della serie su fotografia e verità, articoli dedicati alla fotografia giornalistica che -ad oggi- ancora non ho finito di scrivere, discuto come, in certi casi ed in certe condizioni, la fotografia sappia e possa essere portatrice di verità. Senza voler anticipare troppo questo argomento volevo comunque fosse chiaro che tutte le fotografie viste nel film di Hu Jie appartengono a questa categoria. E hanno un valore enorme, tanto per il documento storico, che per la forza emotiva che emanano, veramente toccante.
Non si tratta fra l’altro unicamente delle foto del corpo senza vita di una delle prime insegnanti uccise durante la rivoluzione culturale. L’anziano protagonista, in un tentativo di documento storico, aveva scattato tutta una serie molto completa di fotografie che documentano tutta la realtà dei fatti: i dazibao offensivi che gli studenti gli avevano incollato su tutti i muri una volta fatta irruzione nell’appartamento, ma anche la casa stessa dove vivevano, i figli all’ospedale in fila secondo l’età o davanti all’altare con l’urna della mamma all’interno di un armadio, la finestra dove, dopo la morte della consorte, l’anziano protagonista si sedeva guardando la strada e aspettando con le lacrime agli occhi il ritorno della moglie.
Tutte queste fotografie, oltre al valore storico e ad essere estremamente toccanti sul piano personale, hanno anche un tocco sorprendentemente moderno. Mi è capitato spesso di vedere dei lavori fotografici dedicati ai propri genitori anziani e morenti, me ne vengono in mente subito tre o quattro, da Mister Toledano a Raffaello Di Lorenzo. Ma più in generale la fotografia d’arte contemporanea spesso esplora un universo intimo legato alla sofferenza personale, e lo fa in maniera visivamente e concettualmente molto vicina a quella delle fotografie che ho visto nel documentario. In particolare, la foto della finestra dove l’anziano giornalista si sedeva, negli anni successivi agli eventi raccontati, ad aspettare la moglie, circondato dai figli in ginocchio sul letto. Si vedono solo le grigie case di fronte, un tratto di strada in diagonale in cui camminano tre uomini, direi con impermeabili e cappello, più simili a dei personaggi americani degli anni cinquanta che a quello che si immagina generalmente dei cinesi. Intensa, triste e indimeticabile.
Con questo non voglio assolutamente dire che l’intento dietro alle foto era quello di fare “mercato dell’arte” sulla sofferenza delle persone o di spettacolarizzare gli orrori della storia. Anzi, tutto il contrario. Già temo le ire possibili di Colberg la cui posizione è chiarissima ogni volta che parla di “pornografia della guerra”, o di Sandro Iovine che sul suo blog denuncia sempre con forza l’utilizzazione artistica di immagini nate per il giornalismo.
Però mi pare che l’arte, e per una volta non voglio intendere questa parola per riferirmi al sistema e al mercato contemporaneo, ma a qualcosa di nobile, astratto e mal definito ma che comunque tutti riusciamo ad immaginare, l’arte dicevo, è spesso legata ai sentimenti più intimi, intensi e personali delle persone. E si può essere artisti anche senza esserlo. Forse una parola più adatta e precisa per indicare quello che voglio dire sarebbe “poeti”. Una poesia che non è fatta solo di parole auliche, una poesia che di fatto incarna il riflesso della vita stessa, della sua tristezza implacabile, dell’orrore, della dignità di chi in queste situazioni cerca solo una cosa: far si che non si dimentichi. E in questo non vedo veramente niente di pornografico. Insomma, questa persona mi racconta la sua storia e mi sento toccato nel profondo, la fotografia è uno straordinario mezzo per avvicinare sul piano umano due persone lontanissime e dalle esperienze di vita agli antipodi. Cosa c’è di male in questo?
Le foto riprodotte nel documentario, comprese quelle scattate in altre occasioni o da altri fotografi, erano quasi tutte veramente eccezionali. Intendo, al di là del documento e del racconto della tragedia personale, le foto erano spesse stupende anche sul punto di vista iconico: epiche e corali. E lo stesso si può dire della maggior parte dei filmati storici presenti. Inquietanti e affascinanti allo stesso tempo, tutti questi ragazzi e ragazze che facevano parte delle guardie rosse, giovanissimi, dalla pelle liscia, il volto adolescente giovane e pieno di vita, simpatico e ridente, che sollevano il pugno chiuso verso l’alto, in una specie di trance collettiva, gli stessi quindicenni che hanno ammazzato di botte i loro professori, senza più considerarli tali, ma solo dei “demoni maligni”, demoni da estirpare in nome della rivoluzione.
Infine, dopo il film c’è stato un lungo dibattito, molto vivo e interessante, dove erano presenti eminenti sinologi, storici della rivoluzione, psichiatri e in generale intellettuali parigini. Devo confessare che, anche se certe persone del pubblico avrebbero fatto meglio ad astenersi piuttosto che blaterare la lor retorica, sono rimasto assolutamente colpito dagli interventi di alcune delle vecchiette presenti. Nonostante il profumo così sgradevole infatti hanno dimostrato una lucidità di pensiero, uno sguardo critico, un’attenzione e una comprensione del film e degli eventi, una chiarezza della visione ben superiore alla mia. Veramente, pensiero lucidissimo e invidiabile.
Alla fine, è un vero peccato che tutto ciò non interessi minimamente quasi a nessuno.


























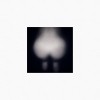



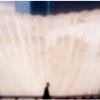












Puoi anche iscriverti al feed RSS dei commenti a questo articolo.