Da diverso tempo volevo andare al Festival Circulations, sperando che non andasse a finire come l’hanno scorso, che per i soliti mille impegni me l’ero lasciato scappare.
Nella metropolitana sono talmente preso dall’ottimo libro di Keigo Higashino “Mukashi bokuga shinda ie” (non credo sia tradotto in italiano) che mi son lasciato scappare la fermata. Scendo quindi a Sablons e mi incammino verso il Bois de Boulogne. È una giornata grigia e nebbiosa, ma non troppo fredda. Arrivo ai primi alberi e mi rendo conto che è proprio qui dove qualche anno fa mi ritrovai per caso assieme ad una ragazza bellissima, un giorno fatto solo di sole e felicità. Proprio qui, dove fra un bacio e l’altro scattai quello che divenne il suo ritratto preferito, subito dopo un gelato mangiato in due dalla stessa coppetta, rubandoselo a vicenda con i cucchiaini di plastica colorata. Come al solito quando ricapito in un luogo speciale, mi guardo intorno cercando di trovare nei luoghi una qualche traccia tangibile della mia esperienza, un segno concreto al di là del mio ricordo giù un po’ appassito. Ma la primavera al Bois de Boulogne non è ancora arrivata e mi rispondono solo i tronchi grigi e muti degli alberi spogli.
Non ho voglia di prendere un pullman, quindi vado a piedi, facendo un po’ attenzione perché nel Bois de Boulogne non mi oriento benissimo e non voglio perder troppo tempo. Passo davanti al museo delle arti e tradizioni popolari, che sembra abbandonato, le scritte tutte scrostate, qualche barbone che dorme avvolto in diverse coperte sotto alla tettoia dell’ingresso. Un cliente entra nel furgoncino di una prostituta coperta solo dal classico vestitino a pelle di leopardo. Mi chiedo se è solo un po’ grossa, o se le cosce importanti e le spalle tradiscono il fatto che sia in realtà un travestito. Un personaggio strano attraversa le sterpaglie sorseggiando una birra. I corridori passano uno dopo l’altro sbuffando fra gli alberi ancora completamente spogli e grigi.
Il Parc de Bagatelles, che ricordo nei fasti floreali estivi completamente stracolmo di gente che mi rimandava con la fantasia alle folle della belle époque, è invece grigio e silenzioso. Ma l’atmosfera è dopotutto pacata e piacevole, non triste. Seguo le frecce che mi portano al festival circulations, guardo senza troppa emozione le prime 2-3 serie di fotografie esposte all’aria aperta e mi infilo nella galleria che espone la prima metà della mostra. Odore di vernice fresca e sottofondo di rumori incongrui tipici dei video d’arte. Poca gente in giro, cosa che permette di ben usufruire delle opere esposte.
Come al solito, buona parte dei lavori che vedo non mi entusiasmano o proprio non mi piacciono. Certo sono piuttosto ben realizzati, le serie sono coerenti in linea con la fotografia contemporanea, però spesso mi sembra che tutti questi grandi concetti siano in realtà un po’ troppo facilotti, che le associazioni mentali siano abbastanza scontate e mi chiedo se l’arte contemporanea di fatto ha poi talmente poco da insegnarci. Le stampe poi sono passabili ma niente di particolare, si vede che son state fatte apposta per il festival, probabilmente senza troppa supervisione e controllo dalla parte degli artisti.
Naturalmente non mancano i lavori interessanti. Le situazioni vagamente incongrue di Amélie Chassary e Lucie Belarbi, il coraggioso reportage fra le prostitute brasiliane di Vincent Catala, le deliziose fotografie americane in piccolo formato di Matt Wilson, la crisi dei trent’anni di Paweł Fabjański, e per finire i misteriosi paesaggi postindustriali ottenuti mischiando fotografia e 3d di David De Beyter.
E poi il mio preferito del Festival Circulations: la serie Mæt di Johansen Per. Foto in grande formato di diversi tipi di cibo crudo infilato e pigiato dentro delle piccole taniche e bottiglie di plastica trasparente. Pesci, salsicce, polli, verdure… L’effetto è disturbante e claustrofobico, tutto questo cibo compresso che viene fuori dal collo della bottiglia quasi come vomito a mala pena trattenuto. Una serie di fotografie che leva veramente l’appetito ed è una splendida e riuscitissima rappresentazione visuale della bulimia del consumismo occidentale. Veramente un livello sopra tutti gli altri lavori esposti.
Sto per andarmene e -come faccio spesso- rifaccio un giro rapido della mostra per fare un riassunto mentale delle fotografie esposte e ben fissare nella memoria i lavori che più mi son piaciuti. Ed ecco che in mezzo alla stanza noto una tavolino di legno che mi era sfuggito. Mi avvicino incuriosito a questo tavolino un po’ dimesso e dall’aria vagamente retrò. Sul tavolo sono posate delle scatolette metalliche, anche queste con un sapore di oggetto antico, il metallo tirato a nudo ma con una bella patina che sembra frutto del tempo. Piccole scatolette che misurano dai quattro, cinque centimetri di lato ad un massimo di una quindicina, in fondo alle quali è posata una fotografia, ricoperta da una specie di resina trasparente che la rende tutt’uno con la scatoletta che la porta dentro.
Dei veri e propri gioielli, bellissimi. In primo luogo la dimensione, questa piccola miniatura, che invita a chinarcisi sopra, a guardare da vicino, a tenerla fra le mani come si fa con gli oggetti preziosi. Poi l’effetto della resina trasparente, che -vagamente irregolare- aggiunge una dimensione tattile e fisica all’immagine, un effetto che ricorda certe proprietà fisiche delle tecniche antiche di stampa. Naturalmente i soggetti malinconici delle foto, vagamente onirici e terribilmente poetici. E poi questa cosa della scatola di metallo, il fatto che alcune sono chiuse a vanno aperte per poter guardare la foto che racchiudono all’interno, l’impressione di aprire un ricordo conservato in un luogo prezioso della mente, un segreto appena confessato. Mi arriva dritta in petto la stessa emozione che provai una delle primissime volte che ebbi la fortuna di ammirare delle splendide autochrome, piccole finestre aperte sul passato.
Mi guardo intorno per scoprire chi è l’autore di questa splendida opera, misto fra fotografia e installazione, mostra che sta tutta su un vecchio tavolino di legno. In un cassetto di questo un foglio trovo il nome che cercavo -Gregor Beltzig- e queste righe:
Le scatole dei sentimenti
Quando avevamo ancora fiducia l’uno nell’altro, scrivevo delle poesie per te,
parlando d’amore, parlando di risa, parlando di quello che sentivo.
Quando avevamo ancora fiducia l’uno nell’altro, ti ho fotto delle foto.
Le tue spalle, il tuo seno, le tue voglie caffellatte e i tuoi capelli.
Ma visto che ormai non ci son più legami fra noi
le parole mi restano bloccate in gola.
Adesso i sentimenti sfuggono dai miei occhi,
ed è così che grido la mia sofferenza al mondo.
Al che non ho più niente da dire, se non di correre a vedere quel tavolino e le sue scatolette riempite di poesia, perché le foto in sé, private della loro scatoletta, nonché nessuna riproduzione del tavolino renderanno mai la magia di quest’opera. Scatole dei sentimenti che mi fa ritrovare la fiducia e la passione nell’arte contemporanea. Un po’ come la mostra di Ville Lenkkeri, ogni tanto fra le tonnellate di masturbazioni cerebrali, lavori insulsi che si vorrebbe poter dimenticare subito, qualcosa di eccezionale lo si finisce per trovare.
Grazie Gregor Beltzig, grazie di cuore.



































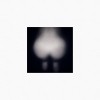



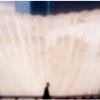











Puoi anche iscriverti al feed RSS dei commenti a questo articolo.