Sole e cielo blu senza una nuvola, da diversi giorni ormai. Fa caldo, non troppo, ma nel primo pomeriggio abbastanza da stare in giro in maglietta. Mi ricordo dalle miei visite negli anni precedenti a Art Paris, che sotto la volta di vetro del Grand Palais si ha un po’ la sensazione di boccheggiare, soprattutto se c’è gente, la luce intensa fa quasi male agli occhi, e dopo qualche ora si è presi quasi da un certo affanno. Oggi mi son quindi preparato in anticipo per fare la mia abbuffata pomeridiana di arte contemporanea: pantaloni corti, camicia leggera e due litri d’acqua.
Faccio un primo giro, come al solito facendo prima tutto il perimetro e per ultime le maglie centrali. Sarà perché il mio centro di interesse è la fotografia, ma dipinti e sculture mi lasciano quasi tutti abbastanza freddo, salvo pochissime eccezioni non c’è praticamente niente che mi metterei in casa, che mi piace davvero. La fotografia invece a mio vedere ne esce molto meglio. Certo ci son tanti lavori che ho già visto ripetutamente e quindi non mi entusiasmano più come la prima volta, qualche opera che purtroppo proprio non incontra il mio gusto e qualche cosetta invece che non mi fa né caldo né freddo, ma nel complesso l’impressione è abbastanza positiva. In ogni caso mi sembra che la qualità delle fotografie esposte sia mediamente superiore a quella degli altri media. Oppure detto più precisamente, mi sembra che le fotografie siano più immediatamente godibili e fruibili rispetto al resto, chiuso nella sua cripticità concettuale. Come se la fotografia, pur artistica allo stato puro come può essere quella esposta ad Art Paris, paragonata alle altre arti figurative, soffrisse meno della maledizione dei ready made e di Duchamp. In ogni caso moltissime gallerie espongono fotografie, molte di più di quanto ricordassi dagli anni passati, il che mi sembra già una bella notizia, e soprattutto un fatto degno di nota. Nonostante i fotografi si lamentino per come va il mercato, sembra invece che gallerie e pubblico si interessino sempre di più alla fotografia.
Arrivato quasi alla fine del mio giro, inizio già a fare un piccolo riassunto mentale, chiedendomi cosa avesse effettivamente ritenuto la mia attenzione, in un certo senso se volesse la pena scrivere un articolo per Camera Obscura, visto che per il momento non ho molto da dire al di la dell’abbondanza di fotografie che contraddistingue Paris Photo 2012.
Ed ecco che lo vedo.
Un grande mobile in legno, a prima vista dall’aspetto vagamente art deco, con incastonate dentro delle foto di Erwin Olaf. Ogni volta che visito Paris Photo (vedi gli articoli scritti nel 2008 e 2010) e Art Paris, Erwin Olaf è immancabilmente fra i miei fotografi preferiti, quindi mi avvicino per non perdere l’occasione di ammirare nuovamente il suo lavoro. La struttura in legno è lunga 3-4 metri e alta un paio, lo stile ricorda i decori delle ultime serie di fotografie di Erwin Olaf, dal gusto retro, un po’ anni trenta. Pannelli in legno intagliato e carta da parati con arabeschi grigio chiari, come se le pareti della struttura fossero i muri dello sfondo di una delle sue foto. Su ogni lato di queste, all’interno di una piccola alcova, sono presenti cinque splendide foto, quasi tutte -se non fosse per un nudo maschile- ritratti di personaggi presi di spalle, che nascondono il volto allo sguardo. Uomini, donne e molti bambini, tutti voltati, come se si vergognassero, come se cercassero di sfuggire allo spettatore, chiusi nell’immobilità vagamente malinconica tipica degli ultimi lavori di Erwin Olaf. Come al solito, le fotografie sono favolose. Composizione, decoro, posa e luce magnifica, alla quale si aggiunge una tecnica indiscutibilmente perfetta e un’ottima stampa. Non posso fare a meno di pensare che secondo me i grandi artisti, oltre alle ottime idee, sono persone che portano alla massima espressione e quasi al perfezionismo puro gli oggetti che costituiscono le loro stesse opere. In ogni caso Erwin Olaf appartiene a questa categoria.
Nei due lati corti della struttura invece sono presenti unicamente due porte chiuse, davanti alle quali è stata posta una sedia con un paio di cuffie appoggiate sopra. Chiaramente un invito a sedersi e guardare attraverso il buco della serratura. Dall’altra parte un video. Un bambino, in piedi accanto alla madre, una donna di mezza età che legge un libro seduta sul letto. Le stesse persone delle foto, la stessa atmosfera, ma questa volta non sono immobili nella fissità della fotografia, si muovono, parlano, cambiano posizione. L’occhio, attraverso il buco stretto della serratura, non riesce ad abbracciare la totalità della scena, è costretto a spostarsi da un punto all’altro, esplorare lentamente la stanza, le persone, i decori. Grazie a questo movimento incessante, a causa dei limiti intrinseci d’osservazione, si scoprono con infinita intensità i dettagli, i particolari che sarebbero rimasti inosservati di fronte alla semplice superficie piatta di una fotografia. L’occhio si sofferma quindi sui decori e gli intagli del legno, la materia tridimensionale della tenda del mobile, il brillare improvviso dell’anello quando la mano della madre entra in un raggio di luce, la sua lunghissima treccia, che tocca quasi terra, le pantofole rosse posate ai suoi piedi, la scultura bianca su l comodino, stretta e lunga quasi come l’ombra della sera.
È chiaro perché keyhole, questo il titolo dell’installazione di Erwin Olaf, sia un’opera sulla vergogna. Al di là del fatto che le persone nelle foto siano quasi tutte di spalle, come se appunto si vergognassero di farsi vedere, spiare attraverso il buco di una serratura è un riferimento inequivocabile, un simbolo chiarissimo di un’attività che può portare con se un misto di voyerismo, curiosità e sensi di colpa. Perché appunto sembra quasi di violare l’intimità delle persone che si trovano al di là della porta, spiarle mentre si trovano in camera da letto, in vestaglia, nella fragilità del quotidiano.
Mi sposto sul lato opposto dell’installazione, per guardare l’altro video. Stessa atmosfera, ma un’altra stanza, questa volta un uomo che tiene il bambino in braccio, leggendo un libro, in uno studio. Mentre legge gli carezza la schiena, lentamente. Nelle cuffie, oltre a rumori soffusi, il respiro forte dell’uomo, quasi a tradire una forte eccitazione sessuale. Questa volta il malessere, questo senso di colpa di spiare ciò che è proibito, si fa molto più intenso, disturbante. Si teme di assistere ad atto di pedofilia, si intuisce tutta l’ambiguità della situazione, senza sapere se di fatto corrisponde al vero, o invece la morbosità è nella propria testa, ci si sta immaginando tutto.
Nel complesso, l’istallazione è veramente geniale. Al di là della bellezza delle fotografie e della perfezione formale della realizzazione, l’esperienza suscitata da keyhole è decisamente intensa. Non si è più semplici fruitori delle immagini, ma il fatto stesso di chinarsi e guardare attraverso un buco della serratura, precipita lo spettatore all’interno della scena, lo trasforma in attore stesso, lo priva del distacco emotivo cui è abituato, immergendolo in una situazione incerta e vagamente repulsiva.
Trovo sempre sorprendente che la quasi totalità delle fotografie siano presentate unicamente come supporto bidimensionale. Certo i fotografi a volte si lasciano andare sulla scelta delle cornici. Spesso le mostre giocano sui formati, o le disposizioni sapienti nello spazio, raggruppare immagini diverse, tanto per i formati che per i contenuti. Ma tutto ciò si limita in generale ad una semplice organizzazione di supporti bidimensionali quali sono le fotografie, senza andare al di là. Erwin Olaf invece, con la sua installazione keyhole, frantuma la bidimensionalità della fotografia, entrando con prepotenza nella realtà che ci avvolge e ci circonda.














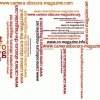




















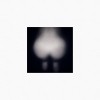




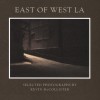










La trovata dell’installazione sicuramente porta ad un gran coinvolgimento e si pone come tentativo di superare i limiti della bidimensionalità fotografica, ma non sono mai riuscito a farmi piacere il lavoro di Erwin Olaf. Mi sembra eccessivamente carico, quasi a voler immettere significato a tutti i costi, con citazioni e schemi noti, limitandosi ad un estetismo perfezionista fine a se stesso, che tenta in tutti i modi di andare oltre ma che non ci riesce a sfiorare. Ovviamente è un’opinione personale
Ciao Sandro, e grazie del commento.
Certo, opinione personale, come del resto la mia che è diametralmente opposta. Non credo si possa dire che uno di noi ha ragione e l’altro torto, di fatto non credo nell’esistenza di un’entità chiamata “Arte” universalmente e immediatamente riconoscibile da tutti. Per certi versi le foto di Erwin Olaf sono in risonanza con la mia sensibilità, mi emozionano e mi affascinano. E la perfezione formale è una caratteristica per me importante. Naturalmente questo non implica che sia per tutti la stessa cosa.
Grazie a te per il bellissimo articolo (e per il blog).
Volevo intendere che è importante anche per me la perfezione formale ma non deve rappresentare il fine quanto uno strumento per raggiungere lo scopo. Forse è dovuto alla formazione di Olaf, che proviene dal mondo della moda, ricordo ad esempio “Private Lives” che incarna perfettamente questo suo modo di porsi in fotografia. Ecco, forse si potrebbe parlare di manierismo, ma percepisco in lui il desiderio di superarlo, perché non si compiace, sempre secondo me, del risultato raggiunto altrimenti non riempirebbe di dettagli “significanti” le sue immagini, non le caricherebbe di pose, colori, tessiture che non voglio mai essere solo “fondali” e che quindi appiattiscono soggetto su scenografia.
Con tutte le dovute differenze storiche e artistiche, Agnolo di Cosimo (il Bronzino) era considerato il maestro del manierismo fiorentino, il più bravo di tutti, ma la sua perfezione tecnica e stilistica fu per lui anche un limite che lo portò a essere sempre sottovalutato, rispetto ad altri grandi, forse meno dotati, o forse meno interessati all’esaltazione della perfezione formale.
Solo di recente è stato riscoperto e qui trovo alcune somiglianze. Ma mentre il “ritrattista” Agnolo riempiva con merletti e decori i suoi soggetti, lasciando che il volto e la posa raccontassero tutto ben oltre il soggetto stesso, Olaf riempie le stanze di dettagli, architetture, oggetti simbolici, in cui modelli in pose innaturali e instabili recitano, non interpretano. In nessun momento ci illudiamo che non siano attori coi muscoli rilassati.
E direi che questo è quanto mai perfettamente contemporaneo
(scusa la prolissità)
Puoi anche iscriverti al feed RSS dei commenti a questo articolo.