Nello scorso articolo Anche il vento è fotografia di questa nostra serie dedicata al rapporto fra fotografia e verità, abbiamo visto come la proprietà fondamentale di interazione fra luce e materiale sensibile, se viene applicata seguendo un procedimento logico e razionale, porta ad includere nella categoria fotografia moltissimi fenomeni che tutto sono salvo fotografie, almeno secondo il senso comunemente attributo al termine fotografia.
Un lettore attento avrebbe potuto ribadire in questo modo: Non ci prendere in giro! Poco tempo fa ci hai dimostrato che le stampe a getto d’inchiostro non sono fotografie, visto che non sfruttano l’interazione fra luce e materia, non sono costituite da sali sensibili, ma sono semplice inchiostro su carta. La maggior parte dei fenomeni che citi non sono più inclusi nella categoria “fotografia” se aggiungiamo una semplice puntualizzazione alla definizione: è fotografia il prodotto unicamente dell’interazione fra luce e materia sensibile.
La precisazione è estremamente ben posta. Fino a questo momento unicamente è sempre stato più o meno implicito. Di fatto non si può farne a meno, perché altrimenti davvero nella definizione di fotografia ci si può mettere anche il panettone e i frutti canditi. Se si rinuncia infatti a unicamente, dicendo che fotografia è il prodotto di un procedimento che, almeno una volta, ha utilizzato l’interazione fra luce e materiale sensibile, allora le stampe inkjet rientrano automaticamente nella categoria, visto che al momento dello scatto si è utilizzata l’interazione fra luce e supporto fotosensibile, e le fasi seguenti sono semplicemente il seguito del processo. Insieme alle stampe getto d’inchiostro però rientrano subito i dipinti di Chuck Close, visto che anche in questo caso almeno un momento di interazione fra luce e materiale sensibile c’è stato. E naturalmente rientrano anche le fotografie dipinte di Araki, quelle graffiate di François Delandre, i fotomontaggi di Jerry Uelsmann, i mordençage di Elizabeth Opalenik. Oltre a queste, qualunque altro prodotto che derivi in modo più o meno stravagante da un unico attimo di interazione con la luce, diventerebbe automaticamente fotografia: se espongo un negativo e me lo mangio divento io stesso una fotografia vivente. Alla lunga qualunque oggetto, in un modo o nell’altro, ha interagito almeno una volta con la luce, quindi la definizione sarebbe veramente troppo vasta. Ne consegue che questa piccola precisazione è strettamente necessaria: fotografia è il prodotto unicamente dell’interazione fra luce e materiale sensibile.
Porre l’accento sull’unicità dell’interazione fotoelettrica eliminando ogni possibile intervento esterno fa sparire buona parte delle difficoltà esposte nell’ultimo articolo. Il vento che soffia, le piante che crescono in primavera, la malinconia nei giorni grigi d’inverno non sono più fotografie. Restano invece fotografie la pelle abbronzata e gli oggetti che si scolorano al sole, ma questo è abbastanza plausibile anche per gli ortodossi della fotografia pura. Sono entità che non siamo abituati a vedere e considerare in quanto fotografie, ma pensandoci un po’ la cosa si fa accettabile anche per i più scettici.
Aggiungendo quell’unicamente, anche molte delle stampe che utilizzano colloidi e pigmenti non sono più fotografie. Questo può dar fastidio a qualcuno che si diletta con antichi procedimenti fotografici, ma del resto, nelle già citate discussioni infinite se le stampe a getto d’inchiostro sono fotografie o meno, i maghi delle tecniche antiche di stampa riconoscono che spesso le stampe pigmentarie, al pari delle stampe inkjet, non sono fotografie, quindi la cosa è abbastanza assodata anche in un pubblico specialistico.
Riprendiamo con qualche dettaglio per esempio il caso della stampa alle polveri. Per ottenerla si sensibilizza un supporto, in generale della carta nobile come la carta da acquarello, con un misto di gomma arabica, zucchero e bicromato di potassio. Il foglio, una volta asciutto, viene esposto per contatto dietro un negativo. Lo strato di gomma zuccherina diventa più o meno appiccicoso a seconda della quantità di ultravioletti ricevuti. A questo punto, facendo cadere a pioggia un pigmento ridotto in polvere, un poco come lo zucchero a velo spolverato su un dolce, questo aderirà maggiormente nelle zone più appiccicose, generando quindi l’immagine.
È chiaro che una stampa di questo tipo condivide molte caratteristiche con le stampe a getto d’inchiostro, in particolare l’immagine è costituita da pigmenti, e non da un materiale che è stato modificato dalla luce. La vera fotografia in questo caso si limita unicamente alla matrice più o meno appiccicosa in seguito all’esposizione agli ultravioletti, fino a che ci si è limitati ad esporre la carta sensibilizzata si è in un ambito puramente fotografico, l’aggiunta del pigmento fa scivolare immediatamente la stampa in una non-fotografia, spolverare con il colore è un’azione simile a quella di Chuck Close quando ricopia una fotografia, è aggiungere colore su una fotografia.
Limitarsi unicamente all’interazione con la luce però pone i suoi problemi, e anche grossi. Di fatto, seguendo un minimo di logica e portando avanti il discorso in modo analogo, significa per esempio che tutte le fotografie virate non sono fotografie. Il viraggio è una pura e semplice reazione chimica, dove la luce non ha assolutamente niente a che vedere. Del resto si può virare una fotografia su carta baritata anche anni dopo averla fissata e asciugata. Si tratta semplicemente di una reazione chimica fra i sali che costituiscono l’immagine e quelli nella soluzione di viraggio, la luce non ha la minima funzione in questo caso. Le fotogafie che sono state virate allora, seguendo la definizione, non sono più fotografie, ma “altro”. Questo è problematico, perché la stragrande maggioranza delle fotografie analogiche del secolo scorso destinate ad essere esposte nei musei hanno subito almeno un leggero bagno di viraggio al selenio per fini protettivi, visto che questo migliora sensibilmente la stabilità dell’immagine e la sua resistenza all’ossidazione.

© Robert Schramm
Altri viraggi comunemente praticati, soprattutto durante il primo secolo di storia della fotografia, sono quelli all’oro e al platino, decisamente più costosi di quelli al selenio, ma ancora più stabili dal punto di vista della conservazione. Oltre a questi, sempre durante gli anni dei pionieri dell’immagine fotografica, molti altri viraggi -tanto per fini espressivi che per conservazione- erano diffusissimi e estremamente vari: al piombo, al rame, al ferro, vari ossalati e citrati, persino all’uranio, per ottenere tutte le possibili tonalità, dal seppia, al rosso, al verde, il blu. I viraggi poi possono essere combinati e localizzati per trasformare immagini in bianco e nero in magnifiche e finissime stampe a colori, come dimostrano ad esempio gli splendidi lavori del maestro dei viraggi selettivi: Mario Stellatelli.
Ebbene, tutte queste immagini, la maggior parte delle stampe analogiche esposte nei musei di fotografie e la maggior parte delle fotografie antiche allora non sono fotografie, visto che non sono il prodotto unicamente dell’interazione fra luce e materiale sensibile. Non sono foto allora quelle dei fratelli Alinari, le albumine di Atget, le fotografie di Julia Margaret Cameron, i paesaggi di Ansel Adams. Ancora una volta però, se sopprimiamo quell’unicamente, sono foto anche i quadri ispirati da fotografie, se lo teniamo siamo costretti a considerare non-fotografiche la maggior parte delle stampe che sono sotto i nostri occhi.
Ma non è finita qui, non è solo sul viraggio che siamo obbligati a puntare il dito. La procedura di stampa della carta al bromuro di argento, per intendersi la procedura di stampa usata probabilmente per almeno il 99,99% delle stampe dagli anni cinquanta del secolo scorso fino all’avvento del digitale, è nota a chiunque abbia praticato un minimo di camera oscura: si espone la fotografia all’ingranditore, la luce sensibilizza i sali presenti nella carta, creando un’immagine latente. La carta viene prima passata in un bagno di sviluppo, i cristalli eccitati dai fotoni reagiscono producendo argento metallico, mentre quelli che non sono stati eccitati rimangono sensibili ma non anneriscono, se si accende la luce si perde quindi la stampa. È necessario allora, dopo un bagno per arrestare l’azione dello sviluppo, procedere al fissaggio, ovvero immergere la stampa in una soluzione che rimuove i sali ancora sensibili presenti nella stampa. A questo punto si può accendere la luce e inizia il lavaggio.
Ancora una volta l’unico momento di interazione fra luce e materiale sensibile è durante l’esposizione all’ingranditore. Il resto è pura e semplice chimica. Il parallelo con l’esempio della stampa alle polveri non potrebbe essere più lampante. In entrambi i casi è un intervento esterno che produce l’immagine, altrimenti questa è solamente latente. Uno strato di gomma arabica più o meno appiccicoso senza nessuna immagine e un foglio di carta baritata completamente bianco, esposto ma non sviluppato. Sono queste, e praticamente solo queste le vere fotografie!
Naturalmente per quanto riguarda i negativi vale la stessa cosa, visto che di fatto quello che si fa con l’ingranditore in camera oscura è fare una foto di un negativo. Anche le pellicole hanno bisogno infatti di essere sviluppate, e anche in questo caso l’azione è puramente chimica, assolutamente senza alcun intervento della luce. Ne consegue che, se vogliamo essere razionali e logici e seguire la definizione data in modo ragionevole, le sole vere fotografie sono i nostri negativi esposti ma non sviluppati, fotografie che nemmeno possiamo guardare. Bel guadagno abbiamo fatto con la nostra definizione di vera fotografia!

© Mathew Brady
Per amor del vero e questioni di completezza devo citare il fatto che esistono delle “vere fotografie” che possono essere viste, delle fotogafie che non hanno bisogno di sviluppo. Un’altra possibile classificazione delle tecniche di stampa è quella che le distingue fra a sviluppo e ad annerimento diretto. La comune carta al bromuro d’argento è a sviluppo, come per esempio la gomma bicromata, il platino, il carbone, il collodio umido. Altre tecniche però sono ad annerimento diretto, come ad esempio la carta salata, l’albumina, il “platino umido”, il Van Dyke Brown. Queste ultime tecniche sono sensibili agli ultravioletti, quindi, anche se non hanno bisogno di sviluppo, vanno fissate se vogliono essere ammirate alla luce del sole. Se vogliamo evitare di fissarle, visto che questo, seguendo la nostra logica di definizioni, le trasformerebbe in non-foto, possiamo comunque vederle sotto una tenue luce gialla. Eccole, le nostre uniche vere foto! Negativi alla carta salata tenuti al buio e osservati, prima che spariscano del tutto, ad una tenue luce gialla!
Nel prossimo articolo ci sarà modo di tirare le conclusioni su questa ricerca di una definizione univoca che stabilisca cosa sia e cosa non sia fotografia. Per ora limitiamoci a sottolineare il fatto che, volendo utilizzare la luce come discriminante, da una parte quasi qualunque cosa che ci circondi appartiene alla categoria di fotografia, dall’altra parte, allo stesso tempo, la maggioranza quasi assoluta di quelle che sono considerate fotografie invece non lo sono.
Se questo non è assurdo…
































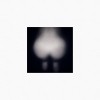



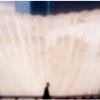












Puoi anche iscriverti al feed RSS dei commenti a questo articolo.