Ormai già qualche anno fa, sulle griglie del giardino di Lussemburgo a Parigi, vidi una di quelle esposizioni che restano nei ricordi come pietre miliari: le fotografie in Cina di Yann Layma.
Me ne innamorai a prima vista, molte foto di Yann Layma le ricordo perfettamente ancora oggi, a distanza di anni, con la stessa chiarezza, lo stesso stupore e ammirazione, e sono entrate a far parte del mio immaginario iconografico sulla Cina.
Studio Cinese e faccio fotografia per mille ragioni, che possono essere riassunte in un banale e lapidario “perché mi va”. Perché sono sempre stato affascinato da ciò che è diverso, lontano, incomprensibile, difficile, sconosciuto. Perché il viaggio è la dimensione di vita che mi è più congeniale, l’unica che mi fa sentire veramente vivo, che possa dare un rilievo all’esistenza, una traccia qualunque di senso. Queste sono le ragioni principali e non sono una persona cui piace identificare dei maestri più o meno spirituali, che vede le scelte della vita come un seguito di eventi chiave imposti dall’esterno, che fa riferimento ad una figura speciale per addossargli i meriti, ma anche la responsabilità, delle proprie scelte. Nonostante questo devo confessare che uno dei momenti che ha determinato prepotentemente il mio interesse tanto per la Cina che per la fotografia è stata la scoperta delle fotografie di Yann Layma.
Le foto della mostra sono raccolte insieme a centinaia d’altre, in uno splendido libro, che naturalmente ho comprato appena trovato da Mona Lisait, intitolato semplicemente China, e che è diventato uno dei miei libri di fotografia preferiti in assoluto. Si possono ammirare le favolose terrazze delle risaie del Sichuan, illuminate da un tramonto che le trasforma nello scenario del sogno più poetico e visionario che si sia mai fatto, monaci in contemplazione su terrazze che si affacciano su dei precipizi che sembrano profondi e inscrutabili come i misteri dell’universo, distese di binari, treni, locomotive fumanti di un mondo monocromatico dipinto solo col bianco della neve e il nero del carbone e dei vagoni, spiagge affollatissime, senza un solo angolo di sabbia o di mare che non sia occupato, distese intricate e interminabili di biciclette, costruzioni di grattacieli immensi e naturalmente una miriade di volti, personaggi, situazioni, fatti quotidiani, che costituiscono un documento corale e toccante di quello che è il teatro della vita.
La forza delle fotografie di Yann Layma mi pare risieda proprio in questo, nella loro universalità. Non si tratta di documentare un conflitto in qualche regione lontana del mondo, o le ultime tradizioni che rischiano di sparire di qualche tribù della steppa. Le fotografie di Yann Layma sono un ritratto a 360° della Cina, una rappresentazione collettiva di quello che è un continente intero, sono la storia di una vita dedicata al viaggio e alla scoperta, di cui si riesce appena ad intuire la portata, l’infinità varietà di situazioni, di cui si immagina a mala pena la quantità sicuramente infinita di aneddoti e storie. Storie e situazioni che si riconoscono immediatamente come universalmente umane, lasciando cadere con un’unica decisa folata di vento le pretese diversità fondamentali fra oriente e occidente, le fotografie di Yann Layma mi pare siano una bella prova di come, alla fin fine, nell’esistenza umana ci sia un sostrato comune indipendente tanto dal colore della pelle che dalla cultura e le tradizioni, un qualcosa cui siamo tutti sensibili.
Inoltre quelle di Yann Layma sono fotografie che, nonostante la coralità e l’apparente eterogeneità, alla fine documentano in modo vibrante e vivido un momento ben preciso, un paese a cavallo fra tradizioni e innovazioni, la Cina come ce la immaginiamo qui in occidente e la Cina moderna e industrializzata, una Cina fatta di trasformazioni che sicuramente già non esiste più, già è lontanissima da quella attuale. Si sente sempre dire che il fotogiornalismo impegnato racconta storie coscientemente articolate attorno ad una scelta coerente e solida di immagini, la famosa serie coerente che tutti consigliano come prerogativa indispensabile di qualunque serio lavoro fotografico. Forse le fotografie di Yann Layma sono nate anche loro come elementi di una serie. Una volta presentate nel libro però non diventano assolutamente aneddotiche, non perdono assolutamente della loro incisività e precisione documentaria. Guardandole sento la stessa coerenza e forza che percepisco in una retrospettiva di un grande nome della fotografia, la stessa impressione di solidità che trovai nella mostra alla MEP di Marc Ribaud. È tutta la vita di Yann Layma che costituisce una serie coerente di immagini.
Dal punto di vista artistico, dove per arte, a difetto di una definizione precisa impossibile da dare, si intende ciò che si vede e si vende nelle gallerie e nei musei di arte contemporanea, a rigor di logica le foto di Yann Layma stanano un po’. Nel panorama odierno, banalizzando provocatoriamente, nella maggior parte di casi quello che conta per la fotografia artistica è il concetto, lo statement, una qualche esplorazione visionaria di una qualche idea esistenziale. Il tutto unito, nella maggior parte dei casi, ad una freddezza e oggettività formale, all’immagine spoglia e priva di sentimento e di pathos, come se non ci fosse nessuna ricerca fotografica al di là dell’idea, se quello che conta in un ritratto è il fatto che quella persona sia davanti alla macchina fotografica e perché, punto e basta. In altri casi invece, al contrario, è proprio la manipolazione dell’immagine a fondare la presupposta artisticità delle immagini: utilizzo di tecniche antiche o alternative di stampa, fotomontaggi al computer, deformazioni dei volti e tutti i possibili interventi che riescano a far uscire in qualunque modo l’immagine dal già visto o dal già fatto, donandogli un carattere individuale e originale. Ma anche stratagemmi stilistici vari in fase di ripresa, come ho già in parte discusso a proposito di Photo Quai e dell’accademismo moderno. vari in fCome se fare semplicemente fotografie non fosse più sufficiente, come se fosse necessario aggiungere qualcosa in più, sul piano concettuale o formale poco importa.
Nelle fotografie di Yann Layma non è presente, né l’asettica oggettività del concettuale né la ben minima manipolazione delle immagini, nella maggior parte si tratta addirittura di diapositive. Guardandole si percepisce subito come non si tratti del tipo di fotografie che girano nelle gallerie, ma piuttosto per un circuito editoriale. Yann Layma fa fotografie un po’ come si faceva cinquant’anni fa, va in giro e coglie la bellezza che vede attorno a lui, senza aggiungere nulla di più e nulla di meno del proprio occhio, del proprio sguardo. Forse per la maggior parte degli addetti ai lavori, degli “artisti” questo implicherebbe l’instaurarsi di una sorta di gerarchia di artisticità fra i loro lavori e le foto di Yann Layma. Personalmente preferisco le foto di Yann Layma. Saranno anche meno artistiche, nell’accezione sviluppata poco sopra, ma sono infinitamente più vicine al mio gusto della maggior parte delle opere che vedo nelle gallerie d’arte. E sono anche più vicine alla fotografia, se mi si permette l’abuso di linguaggio.
Mi pare infatti che ancora la fotografia soffra di un complesso di inferiorità rispetto alle arti visive. Sembra che ancora, nella testa della gente, una foto non possa essere un prodotto nobile e sufficiente a se stesso, e ne do questa definizione per non utilizzare il termine abusato “opera d’arte”, se non è nobilitata da un’iniezione di concettualità o la deformazione delle manipolazioni formali. Le fotografie di Yann Layma in un certo senso superano questo problema, lo trascendono in maniera naturale. Sono bellissime, e per esserlo i mezzi propri alla fotografia gli sono perfettamente sufficienti, non hanno bisogno di cercare altrove nessuna giustificazione esterna aggiuntiva, né nel concetto né nella manipolazione. La cosa divertente è che in un certo senso le fotografie di Yann Layma sono straordinariamente pittoriche, e questo senza utilizzare nessuno degli espedienti proprio del pittorialismo, senza voler cercare di imitare la pittura, ma mantenendo una intatta la purezza fotografica. Sono pittoriche, perché delle grandi opere pittoriche del passato condividono la magnificenza e universalità, perché nella nostra educazione all’immagine siamo abituati a vedere tanta grandiosità solo nei grandi quadri epici e storici del passato.
Dopo questa lunga introduzione passiamo alla fotografia che accompagna quest’articolo, fin dal primo giorno la mia preferita. Delle foto di Yann Layma ce ne sono almeno una decina che meriterebbero un posto in questa categoria “attorno ad una foto” ma questa in particolare è fin dall’inizio quella che più di tutte mi è rimasta nel cuore.
Come già detto (a proposito della foto di Jean Claude Louis) ho sempre avuto un debole per le fotografie scattate nei giorni di intemperie, e gli ombrelli sono sempre stati un elemento importante nel mio personale panteon nostalgico. Il luogo è da sogno: un lago gelido contornato da ripide scogliere rocciose, un chiosco a forma di pagoda su un isolotto sperduto e imbiancato di neve. Cos’è, un tempio? Il gazebo dove un saggio va a meditare o dove si incontrano gli innamorati? Gli alberi sembrano disegnati, i rami sembrano i tratti rapidi e decisi di una calligrafia cinese. Lo sfondo, sembra un dipinto pure lui, perso in una tempesta di neve che stempera i contorni delle cose, li rende dolci e immaginari, come i sogni subito prima del risveglio del mattino. Una barca, lunga e affilata scivola veloce sull’acqua nera e nel vento impetuoso. Tre persone a bordo, qualcuno che rema, qualcuno che si intuisce è subordinato agli altri due, personaggi misteriosi che trasportano chissà cosa, che vanno chissà dove, mentre stanno seduti su una barca da sogno in un lago da sogno e tentano vanamente di ripararsi sotto ai loro ombrelli, dalla neve di una tempesta da sogno.







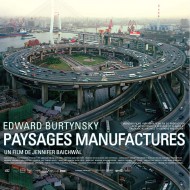




















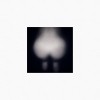



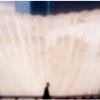












Puoi anche iscriverti al feed RSS dei commenti a questo articolo.